
Forum
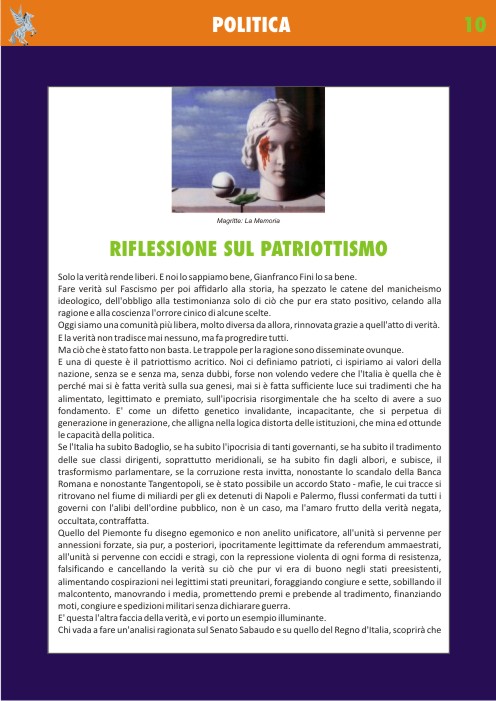
Francesco Diacceto
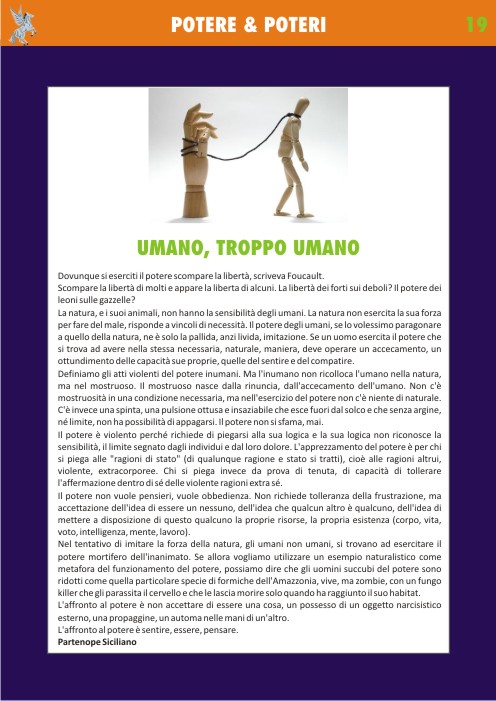
L’autore non me ne vorrà se commento il suo
articolo (mi riferisco a “Umano, troppo umano” a
firma
Partenope Siciliano) apparso sul n. 0 di
Confini ma credo che una rivista, sia pur
telematica, si basi anche sul dibattito che
riesce a suscitare, sull’essere
agorà.
Non ho onestamente compreso la filosofia a base
dell’articolo. Però non credo che l’autore abbia
voluto scrivere un “pezzo” antropologico” né,
tantomeno, un pezzo “metafisico” o “anarchico”.
Riferito alla prima ipotesi, non lo credo
perché, com’è stato ben detto, la natura non
conosce sentimento: negli animali è puro
istinto. Invece, nell’essere umano, che pure
animale è, la capacità di apprendere, di
conoscere, di elaborare ha portato alla
sovrastruttura, alla cultura, all’azione
programmata farcita di sentimento: odio, amore,
bramosia, desiderio, cupidigia; aspetti che
notoriamente l’animale ignora. Tutt’al più
pratica una specie di legge del taglione.
E’ comunque una “legge” animale l’istinto
dell’autoaffermazione, l’emergere dalla massa,
l’uscire dal gregge, per l’essere umano farsi
egregio. Il leone, il lupo, e tanti e tanti
altri ancora, lottano per la supremazia nel
branco. Perché non dovrebbe farlo l’animale-uomo
con qualche chance in più?
Se ne può dedurre che l’autoaffermazione per
l’essere umano, supportato dalla cultura e non
dalla sola forza, porta alla rappresentazione
delle proprie idee ai fini della ricerca del
consenso su di esse: ed è la “forza” di tale
consenso, il numero dei consenzienti, a
determinare la supremazia di un essere umano su
altri esseri umani; in una parola, a determinare
carisma e potere.
Non credo, quindi, che il riferimento sia
metafisico in quanto è tipico dell’essere umano,
secondo il principio socratico di ogni atto
morale, "compiere
ciò che è proprio a ciascuno",
ricollegandolo da un lato a un qualcosa che è
radicato in lui, all'areté,
all’eccellenza, all’abilità, alla capacità, ma
dall'altro lato all’indipendenza dal giudizio
degli altri. Può sbagliare ma si può correggere
(tipica dell’essere umano) al fine di mirare
sempre alla felicità del singolo e, attraverso
la sommatoria, ovvero la politica, alla felicità
della polis. Del resto, questo compete al capo.
Che proprio perché tale non deve attuare quanto
gli viene detto se non ne é convinto ma, in
virtù del consenso generale ricevuto, del
carisma goduto, far sì che siano gli altri a
seguire il suo volere. Altrimenti che capo
sarebbe?
Certo. Un capo, in altre parole il detentore del
potere, non può sfuggire all’impianto
democratico di un contesto, di una comunità, di
un Paese. Perché altrimenti sarebbe dittatura,
un potere esercitato non sul consenso bensì
sulla forza mercenaria. Diversamente, è
democrazia l’impianto che regola la vita
politica, civile e sociale. E, quindi, allo
scemare di un consenso si sostituisce un nuovo,
maggioritario consenso.
Non credo neppure che il riferimento possa
essere un inno all’anarchia. Perché in ogni
società civile si registra la presenza di un
potere: semmai si può discutere sugli impianti,
esistenti o meno di partecipazione democratica,
ma non è detto che, per “osteggiare” il potere,
occorre “sentire, pensare ed essere” perché può
anche succedere che attraverso tali
atteggiamenti si favorisca lo stesso potere. Si
potrà discutere se lo merita o no, ma non se ne
può prescindere. E, peraltro, se l'anarchia
(mancanza di governo/potere) è una concezione
politica basata sull'idea di un ordine fondato
sull'autonomia e la libertà degli individui,
essa è automaticamente contrapposta a ogni forma
di Stato e di potere costituito. E, quindi,
fondata sul senso di responsabilità di ciascuno
nell’esercitare la propria libertà, senza che vi
sia correttivo alcuno quando la manifestazione
della libertà dell’uno tenderà inevitabilmente a
prevaricare la libertà dell’altro. E ciò perché
gli esseri umani, tra loro, sono notoriamente
diversi. Non solo somaticamente ma anche
psicologicamente, culturalmente, economicamente.
Il vigore fisico, l’arguzia, il sapere, la forza
economica rende paradossalmente “più liberi”.
Per cui, non avrebbe senso la “libertà” se non
coniugata con “giustizia” e quindi con un potere
che possa garantirla.
Diversamente, neppure la politica avrebbe più
senso poiché non si dovrebbe mirare più alla
felicità della polis bensì alla salvezza, alla
“felicità”
del
singolo. Il che mi sembrerebbe un po’
egoistico. Non solidaristico. Antisociale. Non
umano. E ciò nonostante abbiano teorizzato
l’anarchia, direttamente o indirettamente, barba
di filosofi del calibro di Proudhon, di Moro, di
Condillac, di de Sade, di Godwin, di Bakunin.
L’autore
Partenope Siciliano, peraltro, apre
l’articolo citando Foucault e una sua
affermazione:
ovunque
si eserciti il potere scompare la libertà di
molti a favore della libertà di pochi.
Certo. Questo riporterebbe all’anarchia ma
Foucault, nella sua “analisi” del potere, ci
chiarisce le idee. Sensibile alla cultura
marxista, ribalta tuttavia il discorso sul “soggetto
della storia” non riconoscendo una “classe
repressa” portatrice inevitabile di
sviluppo. Elabora piuttosto una "microfisica del
potere", come emerge dalla raccolta dei suoi
scritti cd. “politici”, nella quale il potere "non
è qualcosa che si divide tra coloro che lo
possiedono e coloro che lo subiscono….
Deve
essere invece analizzato come qualcosa che
circola,…. che funziona solo a catena…..Il
potere funziona, si esercita attraverso
un'organizzazione reticolare.". Sembra quasi
di leggere Weber e la sua teoria sui “servi di
rango”. Orbene, perché un’organizzazione di
potere mal gestito cessi il suo esercizio quale
sistema migliore di contrapporgli un’altra
organizzazione dai positivi intenti?
A meno che
Partenope
Siciliano non intenda riferirsi
specificatamente al “potere all’interno di un
partito”, alla radicata persistenza di una
qualsivoglia classe dirigente. Se così fosse,
credo possano valere le stesse identiche
riflessioni a proposito della società della
quale i partiti, nel loro ruolo di intermediari,
ne sono comunque uno spaccato. Con un’aggiunta.
Un tempo, era un piacere assistere ai dibattiti
nelle occasioni assembleari. Argomentazioni che
volteggiavano in armoniche acrobazie,
dissertazioni che ascendevano a vette inviolate,
esposizioni che catturavano l’animo e lo
esponevano all’emozione. Qualcuno potrà dire che
erano “impressioni” di gioventù. Per certi
aspetti, potrebbe anche aver ragione.
Certo, il dibattito, la dissertazione elevata,
la ricerca della motivazione interiore era il
collante che teneva unito un corpo, grande o
piccolo che fosse, che altrimenti avrebbe potuto
disgregarsi. Ed anche fenomeni di iato sono
stati superati da un forte, orgoglioso senso di
appartenenza. Ma i giovani, si sa, diventano
adulti e, senza guide valide ad accompagnarli
nella transazione generazionale, perdono
quell’entusiasmo prospettico per adeguarsi a un
inconcludente, spesso, e a volte becero
perbenismo manieroso quando non a un inefficace
conformismo, dando così vita ad una stasi
evolutiva anche per le generazioni successive.
E’ accaduto il ’92 e le successive rivoluzioni.
Ma tutte le rivoluzioni hanno un difetto: quelle
di mangiare sé stesse se manca un radicamento di
nuove idee, di nuovi valori, se si instaura e si
consolida una pianificazione centralizzata, se
un costruttivo, partecipativo, dibattito è
assente, se non vi è una prospettiva
coinvolgente. Quando accade ciò, la comunità, la
società, la massa involve, subentra il mugugno
alla speculazione intellettuale e resta
l’opportunità quando non l’opportunismo, senza
entusiasmi. E’ ciò che è accaduto.
Non sono più le Idee a far la differenza. Essa,
vera o presunta, avviene su altre basi:
rateazione o meno dell’MU, disegno di legge o
emendamento al testo anti-corruzione per
modificare il finanziamento ai partiti,
ampliamento o diminuzione della flessibilità in
entrata e in uscita, ecc.
La vincente cultura dell’immagine su quella
alfabetica ha fatto il resto: il “valore” è ciò
che appare, è quello che s’inalbera a simbolo di
uno (pseudo) status. E, infatti, secondo le
tecniche di comunicazione pubblicitaria
occidentale occorre avere un look adeguato,
essere snelli, scattanti, abbronzati. E laddove
la natura è stata matrigna, c’è l’emulazione,
quella della peggior specie: riempirsi di
piercing e mostrare il bordo delle mutande con
impressa la griffe che fuoriesce dai pantaloni a
vita bassa. Già, perché nel sovvertimento
culturale si perde il senso del ridicolo il
quale, dilagando e coniugandosi con l’esigenza
di (pseudo) modernismo, determina la generale
scomparsa dello spirito critico, conniventi
famiglia e scuola. Oggi siamo allo
scimmiottamento di dive, pagate milioni di
dollari ma alcoliste e drogate.
Il fatto, in conclusione, è che, a prescindere
dal potere, la società e i suoi rappresentanti,
non riuscendo ad auspicare un “nuovo”, si
adagiano sul “nulla” senza che un briciolo di
“follia” (per dirla alla Foucault) prefiguri un
“meglio”.
E all’intervenuta, generale supinazione
neghittosa ha fatto sponda la perdita di
memoria.
Nietzsche, tanto amato dal mondo della
“liberale” destra, nel 1878 prese le distanze
sia da Schopenhauer che da Wagner e, a proposito
di tanti liberali, dedicò a Voltaire (pur non
sposando l’Illuminismo) la sua opera “Umano,
troppo umano. Un libro per spiriti liberi”
nel quale scriveva che “il
vantaggio della cattiva memoria è che si gode
parecchie volte delle stesse cose per la prima
volta.”.
Massimo Sergenti